Uno studio condotto dalla McGill University ha identificato un secondo orologio cerebrale, regolato dalla dopamina, che potrebbe spiegare le alternanze tra mania e depressione nel disturbo bipolare. Questa scoperta non solo apre nuove prospettive nella comprensione della patologia, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui vengono sviluppati i trattamenti farmacologici e terapeutici per questa condizione psichiatrica complessa.
Il disturbo bipolare: una patologia enigmatica
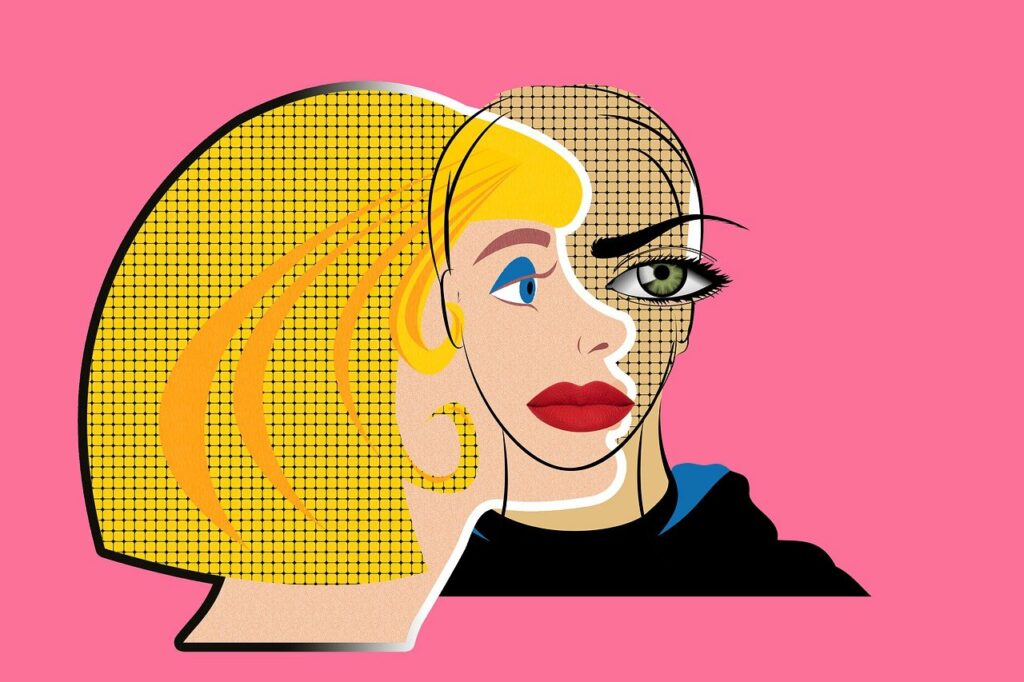
Il disturbo bipolare è una condizione cronica dell’umore che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e si manifesta con episodi alternanti di mania ed estrema depressione. La sua natura imprevedibile influisce profondamente sulla qualità della vita, compromettendo la stabilità emotiva, i rapporti interpersonali e l’autonomia lavorativa.
Nelle fasi maniacali, il paziente sperimenta un’intensa euforia, accompagnata da energia incontenibile, ridotto bisogno di sonno, comportamenti impulsivi e, nei casi più gravi, episodi psicotici. La fase depressiva, invece, si caratterizza per una profonda apatia, senso di disperazione, perdita di interesse per le attività quotidiane e, in alcuni casi, pensieri suicidari. Nonostante le numerose ricerche condotte negli ultimi decenni, la causa biologica esatta di queste oscillazioni è rimasta a lungo un mistero.
La scoperta del secondo orologio cerebrale: una svolta nella ricerca
Il team guidato dal professor Kai-Florian Storch della McGill University (Canada), ha individuato un secondo orologio biologico nel cervello, capace di influenzare direttamente le fluttuazioni dell’umore. Questo sistema lavora in parallelo con il ritmo circadiano, il ciclo naturale che regola il sonno e la veglia attraverso il nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo.
A differenza del ritmo circadiano principale, che risponde ai segnali luminosi per regolare i livelli di melatonina e altre funzioni fisiologiche, questo secondo orologio è modulato dalla dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per la regolazione dell’energia, della motivazione e del sistema di ricompensa. La scoperta più rilevante è che nei pazienti bipolari questo orologio dopaminico risulta desincronizzato rispetto al ritmo circadiano tradizionale. Questo disallineamento potrebbe spiegare i rapidi cambiamenti di umore: un’eccessiva attivazione di questo sistema porta alla mania, mentre una sua riduzione determina il passaggio alla depressione.
Come è stata condotta la ricerca?
Per verificare questa ipotesi, gli scienziati hanno condotto esperimenti su modelli animali, manipolando geneticamente e farmacologicamente i neuroni dopaminergici nel mesencefalo. Durante le osservazioni, hanno scoperto che interrompendo l’attività di questi neuroni era possibile stabilizzare i comportamenti ciclici simili a quelli osservati nei pazienti bipolari. Questa evidenza ha rafforzato l’ipotesi secondo cui il sistema dopaminico funzioni come un secondo orologio interno, il cui malfunzionamento è alla base delle alterazioni dell’umore.
Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio è che questo secondo orologio sembra essere attivo solo nei pazienti bipolari, mentre nei soggetti sani rimane inattivo o sincronizzato con il ritmo circadiano principale. Questa differenza potrebbe rappresentare una chiave diagnostica importante, oltre che un nuovo obiettivo terapeutico per il trattamento della malattia.
Implicazioni terapeutiche e nuove prospettive di trattamento
Attualmente, il trattamento del disturbo bipolare si basa principalmente sull’uso di stabilizzatori dell’umore come il litio, antipsicotici atipici e, in alcuni casi, antidepressivi. Tuttavia, questi farmaci non agiscono direttamente sulla causa delle fluttuazioni dell’umore, ma piuttosto cercano di attenuarne gli effetti. La scoperta di un secondo orologio cerebrale regolato dalla dopamina apre la strada a nuove strategie terapeutiche più mirate, capaci di intervenire direttamente sul meccanismo alla base del disturbo.
Gli scienziati stanno già lavorando allo sviluppo di farmaci in grado di ristabilire la sincronizzazione tra il ritmo circadiano principale e il sistema dopaminico. L’obiettivo è ridurre la gravità e la frequenza degli episodi maniacali e depressivi, senza gli effetti collaterali spesso associati agli attuali trattamenti farmacologici. La possibilità di modulare selettivamente l’attività di questo orologio dopaminico potrebbe rappresentare una svolta epocale nella gestione del disturbo bipolare.
Le domande ancora aperte e le prossime sfide
Nonostante i progressi compiuti, molte domande rimangono senza risposta. Gli scienziati devono ancora chiarire quali siano i fattori genetici ed epigenetici che determinano l’attivazione di questo secondo orologio nei pazienti bipolari. Inoltre, resta da comprendere in che modo i segnali ambientali, come lo stress o l’alimentazione, possano influenzare questo sistema dopaminico e aggravare la sintomatologia.
Un’altra sfida cruciale riguarda lo sviluppo di biomarcatori affidabili per identificare precocemente il malfunzionamento di questo secondo orologio cerebrale. Se fosse possibile individuare la desincronizzazione nei soggetti a rischio, si potrebbero adottare strategie preventive prima che il disturbo si manifesti in forma conclamata.
Un nuovo orizzonte nella psichiatria
La scoperta di un secondo orologio cerebrale regolato dalla dopamina rappresenta una svolta nella comprensione del disturbo bipolare. Per la prima volta, si identifica un meccanismo specifico alla base delle fluttuazioni dell’umore, offrendo una spiegazione neurobiologica chiara per una condizione che, fino a oggi, è stata trattata in modo sintomatico più che causale.
Anche se il cammino verso trattamenti più efficaci è ancora lungo, questa ricerca dimostra quanto sia fondamentale adottare un approccio multidisciplinare nello studio del cervello, integrando neuroscienze, psichiatria e genetica. Ogni nuova scoperta in questo campo ci avvicina a una comprensione più completa del disturbo bipolare, aprendo la strada a soluzioni innovative che potrebbero trasformare la vita di milioni di persone in tutto il mondo.
Fonti
McGill University, Science Advances (2025)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Journal of Neuroscience (2025)
